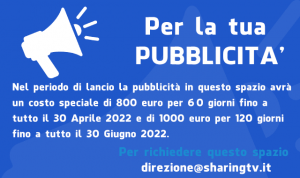Ventuno anni di carcere per colpa di una consonante

Muerte o muerse.
Morto oppure oggetto ingombrante, nel caso una pala meccanica per lavori edili.
Una consonante, scivolata via come una scheggia in dialetto pugliese, fa la differenza.
E provoca un disastro: Angelo Massaro, lavoratore nel mondo della segnaletica stradale, si fa ventun anni di carcere sulla base di quella parola incerta, o meglio di due brevi intercettazioni telefoniche sull’utenza di casa.
Siamo nel 1995 e c’è stato un delitto cui Massaro secondo gli investigatori potrebbe non essere estraneo.
Lo ascoltano e captano quelle poche parole: la moglie vuol sapere se il marito porterà il piccolo Antonio, il loro figlio, a scuola.
Si fa tardi, ma lui replica: «Io sto ancora a San Marzano che devo andare a portare il morto e che sto sopra la strada… che devo portare a Fragagnano».
Poco dopo, alle 9.13 del mattino, l’uomo richiama: «Eh sì, prendi e accompagnalo, perché prima di mezz’ora non ci arriviamo, che finché lo agganciamo di dietro qua».
Può essere che Massaro parli, fra ciucci e pannolini, di un morto da agganciare e trasportare in una sorta di macabro corteo funebre sulla strada?
Può essere che abbia la freddezza agghiacciante di dialogare così con la consorte, accennando tranquillamente alla vittima di un delitto?
Nell’Italia delle intercettazioni sconsiderate, questa è forse la più incredibile.
Ma vale una condanna pesantissima, firmata dalla corte d’assise di Taranto e confermata dalla corte d’appello e dalla Cassazione.
Non ci sono altri elementi, solo sospetti, nemmeno il corpo dello sventurato Lorenzo Fersurella, mai ritrovato, ma solo quelle due chiamate insignificanti dove i diabolici coniugi mischierebbero vita privata e delitti agghiaccianti, con tanto di incomprensibile spostamento della salma a una settimana dal molto presunto omicidio.
È tutto cervellotico e senza alcun riscontro, ma non importa: Massaro resta in prigione dal 15 maggio 1996 al 23 febbraio 2017, quasi ventun anni.
Poi a Catanzaro arriva la revisione che fa a pezzi quelle pronunce appoggiate solo a una traballante consonante: muerte che forse era muerse.
Ma ormai il danno è fatto.
E non si tratta di un caso isolato. Macché.
Il 10 dicembre 1997 in Sardegna viene ammanettato Pietro Paolo Melis, un imprenditore agricolo.
L’accusa è devastante: aver partecipato al rapimento di Vanna Licheri, una delle tante vittime dell’industria dei sequestri, concluso con la morte dell’ostaggio. «È un errore, state sbagliando, sono innocente».
Melis, incensurato e senza alcun collegamento con la criminalità sarda, resta in galera più di 18 anni e mezzo.
Le prove?
Due fulminee intercettazioni ambientali, captate nell’auto di uno dei presunti componenti della banda, Giovanni Gaddone.
Chi è il suo interlocutore?
Tempo dopo, all’interno del Consorzio agrario di Nuoro, Melis beve un caffè con Gaddone. Per chi indaga, è la quadratura del cerchio.
Ma quella voce ignota è davvero quella di Melis, per il resto estraneo a tutta quella storia?
C’è un rumore di fondo, fortissimo, fino a 140 decibel, che confonde i con ma soprattutto il giallo di quelle frasi, coperte da un suono infernale, e attribuite a forza a Melis.
Dopo 18 anni, Perugia cancella tutto.
E chiarisce l’equivoco, uno dei tanti, troppi errori di una lunga e controversa stagione di cronaca giudiziaria.